Amos Oz: La guerra che non finisce mai / Amos Oz: The war that never ends
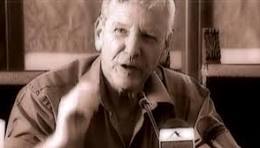
In un Medio Oriente che vive sospeso tra tregue fragili e conflitti ricorrenti, la voce di Amos Oz, tra i più lucidi e controversi scrittori israeliani, resta un punto di riferimento per comprendere l'intreccio inestricabile tra identità, politica e destino collettivo. Oz (lo scrittore e saggista israeliano, è morto il 28 dicembre 2018 a Tel Aviv, all'età di 79 anni) non parlava solo di Israele: parlava di ogni nazione intrappolata nella propria storia, di ogni popolo che, invece di chiudere le guerre, le eredita come si eredita un cognome. La sua opera è un atlante morale, ma anche un atto di accusa verso chi trasforma la memoria in arma.
Negli ultimi mesi, mentre la diplomazia internazionale fatica a produrre soluzioni concrete per il conflitto israelo-palestinese, le parole di Oz tornano con una forza nuova. Nei suoi saggi e nei romanzi, da Una storia di amore e di Tenebra a La scatola nera, emerge sempre un'idea chiave: la pace non è un dono che si riceve, è un mestiere che richiede fatica quotidiana. Questa visione stride con la narrativa politica dominante, che spesso alterna promesse solenni a ritorsioni immediate, senza mai stabilire una linea di compromesso duratura. Oz, che nella giovinezza fu un convinto sostenitore del movimento laburista e un promotore del dialogo con i palestinesi, è stato al contempo un critico feroce di ogni semplificazione. Per lui, la storia di Israele non si riduceva a una favola fondativa di redenzione, né a un racconto di sola oppressione. Era piuttosto una trama di traumi reciproci, dove ogni verità porta con sé un'altra verità, spesso inconciliabile.
Sul piano geopolitico, la lezione di Oz è scomoda perché non si presta a essere strumentalizzata. Non offre slogan facili né una divisione netta tra "giusti" e "colpevoli". In un'epoca in cui la diplomazia internazionale tende a polarizzarsi, la sua insistenza sulla "coabitazione tra narrative" appare come una forma di resistenza intellettuale. Secondo Oz, accettare l'esistenza di due memorie storiche in conflitto non è segno di debolezza, ma il primo passo verso una pace reale. Oggi, mentre la regione assiste a una nuova spirale di violenza, la domanda che Oz avrebbe posto resta sospesa: siamo disposti a vivere accanto a chi ha un ricordo diverso, persino opposto, del nostro stesso passato? La sua risposta era netta: non esiste altra via. "Tra l'amore e la tenebra", scriveva, "bisogna trovare la luce sufficiente per non accecarsi". Una luce fioca, forse, ma ancora accesa.
Giovanni Valerio
Amos Oz: The war that never ends
In a Middle East suspended between fragile truces and recurring conflicts, the voice of Amos Oz, one of Israel's most lucid and controversial writers, remains a reference point for understanding the inextricable tangle of identity, politics, and collective destiny. Oz (the Israeli novelist and essayist, who died in Tel Aviv on December 28, 2018, at the age of 79) did not speak only of Israel: he spoke of every nation trapped in its own history, of every people who, instead of ending wars, inherit them as one inherits a surname. His work is a moral atlas, but also an indictment of those who turn memory into a weapon.
In recent months, as international diplomacy struggles to produce concrete solutions to the Israeli-Palestinian conflict, Oz's words resurface with renewed force. In his essays and novels—from A Tale of Love and Darkness to The Black Box—one key idea always emerges: peace is not a gift one receives, it is a craft that requires daily labor. This vision clashes with the dominant political narrative, which often oscillates between solemn promises and immediate reprisals, without ever establishing a lasting line of compromise. Oz, who in his youth was a staunch supporter of the Labor movement and a promoter of dialogue with the Palestinians, was at the same time a fierce critic of any simplification. For him, the history of Israel was neither a founding fable of redemption nor merely a tale of oppression. It was rather a tapestry of reciprocal traumas, where each truth carries with it another truth, often irreconcilable.
On the geopolitical level, Oz's lesson is uncomfortable because it cannot be easily instrumentalized. It offers no simple slogans, no clear division between "innocent" and "guilty." In an age when international diplomacy tends to polarize, his insistence on the "coexistence of narratives" appears as a form of intellectual resistance. According to Oz, accepting the existence of two conflicting historical memories is not a sign of weakness, but the first step toward real peace. Today, as the region faces yet another spiral of violence, the question Oz would have asked still hangs in the air: are we willing to live alongside those who hold a memory different—perhaps even opposed—to our own past? His answer was unequivocal: there is no other way. "Between love and darkness," he wrote, "one must find enough light not to go blind." A dim light, perhaps, but still burning.
Giovanni Valerio
